

Me lo ricordavo bello, ma non così bello.
Conobbi la musica di mister Bragg nel 1984, con un disco (eh, si... Era proprio così che si diceva, allora: disco. Non usa più...) che si intitolava Brewing Up With Billy Bragg. Ma era già da un po' di tempo, almeno un anno, che avevo sentito parlare di questo inglese dal notevolissimo nasone che se ne andava in giro, di palco in palco (di piccolo palco in piccolo palco...), trascinandosi dietro una chitarra elettrica e un amplificatore e presentandosi al mondo in questa maniera folgorante: “Quando un artista folk sale sul palco con la sua chitarra, può pensare di essere James Taylor o Bob Dylan. Quando ci salgo io, penso di essere i Clash”.
E, credete a me: appena appoggiavi la puntina (eh, già... Proprio la puntina del giradischi) sui solchi del vinile e It says here letteralmente esplodeva, capivi che era vero. Ci si poteva fare airwaving, sulla prima canzone di Brewing up... Pareva veramente che fossero Joe, Mick, Paul & Topper, a suonare. Ed invece era Billy Bragg quello che stava incendiando, se non il mondo, il tuo mondo, in quel momento. Pennate secche sulle corde della chitarra, riff veloci e compatti e una voce che dovevi avere i testi sotto mano, altrimenti le parole non le capivi: non era proprio l'inglese che ci insegnavano a scuola quello che usciva dalle casse del mio stereo da poveretto.
E che belle cose aveva messo insieme, il laburista Billy Bragg. Elegie per la povera gente e fucilate al Sun e al Daily Mirror (quei giornalacci dove “la politica si mescola al bingo e alle tette/ in un gioco di soldi e cifre”), canzoni piene di rabbia, di furori nient'affatto astratti, di ironia e di amore per la vita. Come era possibile non rimanere incantati da uno che se ne usciva in questo modo: “Sono cresciuto con la soggezione/ Per la ragazza della porta accanto”? Si, era decisamente per me che cantava, il nasone: per la mia terribile timidezza e per tutte quelle volte che me ne stavo in disparte, per conto mio, a spiare le vite degli altri, ben più che per le mie incazzature adolescenziali, quasi sempre sorde e cieche come le incazzature a quell'età hanno la ventura di essere.
Avevo appena compiuto diciott'anni, nel 1986, quando uscì il “difficult third album” di Billy Bragg che apriva con un Johnny Marr schitarrante in una canzone magnifica dedicata alla brunetta Shirley (“I'm celebrating my love to you/ with a pint of beer and a new tattoo”), una tipa interessante, pareva (“Shirley, sei tu l'unico motivo che mi fa alzare dal letto prima di mezzogiorno”). Nelle chiacchierate sulla poesia con l'uomo delle tasse ci trovavi l'amore e la politica, “thoughts of lust” e protest songs urlate a pieni polmoni in faccia a Margaret Thatcher e Ronald Reagan. E a volte non capivi di che cosa si stesse parlando, veramente: Billy Bragg non ignorava, infatti, che si può finire per amare appassionatamente la politica anche solo perché non c'è proprio nient'altro, intorno a te, da poter amare (“Un uomo può passare un bel po' di tempo/ Chiedendosi cosa avesse in mente Jack Ruby/ E il tempo è tutto ciò che mi resta qui senza di te”). Non c'era nessuna autoindulgenza, nella sua poetica, e la retorica magari veniva sfiorata ma (quasi...) sempre evitata, nella consapevolezza che una canzone politica non dovrebbe mai assomigliare ad un comizio. Dirà qualche anno più tardi, in una delle sue canzoni più belle, Waiting For The Great Leap Forward: “Mischiare pop e politica, mi chiedono che senso abbia/ io rispondo offrendo il mio imbarazzo e le mie solite scuse”. E sembra proprio di avercelo davanti, quel suo sorriso gentile.


La Motown fu una vera e propria fabbrica di hit da classifica, negli anni Sessanta: canzoni pop scritte da neri e cantate da neri, ma pensate per poter piacere anche ai bianchi (il che è come dire "scritte per tutti", naturalmente), caramelle che, nei primi anni di vita del marchio, giravano quasi esclusivamente a 45 giri, dolcificate con fiati, violini e voci di supporto di taglio gospel, il ritmo quasi sempre a quattro tempi. Sì, sfornava hit a getto continuo, la Motown: Smokey Robinson and the Miracles erano Motown, così come Martha Reeves and the Vandellas; i Temptations erano Motown, come Gladys Knight; le Supremes di Diana Ross erano Motown, come i Four Tops di Levi Stubbs.
Il periodo d'oro dell'etichetta fu senza dubbio quello che va dal 1963 al 1968: gli scrittori di canzoni della Motown, prima il trio Holland-Dozier-Holland e poi Norman Whitfield e Barrett Strong

(quelli, per capirci, di I heard it through the grapevine. Tra le altre cose...), fecero ballare l'America (e non solo l'America) negli anni delle lotte per i diritti civili e della guerra in Vietnam, della liberazione sessuale e del rock che diventava adulto con Bob Dylan, i Beatles, gli Stones e metteteci pure chi volete voi, che io rischio di mettercene troppi.
Quando le cose vanno a pezzi, canta Billy Bragg, i Four Tops rimangono al loro posto. Perché le loro canzoni sono sempre lì, e sono state scritte proprio per te. E' una storia commovente, quella che viene raccontata: una cronaca di poveri amanti sbagliati, di violenza domestica e di ferite dell'anima, quelle per cui non c'è cura.
Alla protagonista resta però la forza di metter su un nastro (un nastro...) dei Four Tops. E di piangere le lacrime di Levi Stubbs.
“When the world falls apart, some things stay in place”: se la musica pop significa per voi quello che significa per me, non c'è bisogno di dire altro.
Un capolavoro, avrete inteso.
 With the money from her accident
With the money from her accident

 E' stato in Inghilterra, e attraverso la pratica dell'inglese, che ho imparato alcune cose essenziali intorno alla prosa. In primo luogo che lo scopo della prosa non è principalmente l'ornamento, ma è quello di comunicare dei significati. Questa per me era una novità. Faceva a pugni con l'intera temperie dell'educazione retorica a cui ero stato esposto.
E' stato in Inghilterra, e attraverso la pratica dell'inglese, che ho imparato alcune cose essenziali intorno alla prosa. In primo luogo che lo scopo della prosa non è principalmente l'ornamento, ma è quello di comunicare dei significati. Questa per me era una novità. Faceva a pugni con l'intera temperie dell'educazione retorica a cui ero stato esposto.
 non sembra Carlo Verdone che interpreta Fausto Amodei in un biopic de noantri, diretto, che so, da una Wilma Labate, regista 'de sinistra' col vento in poppa perché piace taaanto a Bertinotti?). E che dire poi di quei poveri diavoli ammazzati a Reggio Emilia dalla polizia di Tambroni 'per riparare al torto' di chi si è scordato di Duccio Galimberti?
non sembra Carlo Verdone che interpreta Fausto Amodei in un biopic de noantri, diretto, che so, da una Wilma Labate, regista 'de sinistra' col vento in poppa perché piace taaanto a Bertinotti?). E che dire poi di quei poveri diavoli ammazzati a Reggio Emilia dalla polizia di Tambroni 'per riparare al torto' di chi si è scordato di Duccio Galimberti? Pensate: in Italia, ben otto anni prima di George Romero e del suo straordinario, seminale, “La notte dei morti viventi”, Fausto Amodei si inventa una storia da brividi che mescola, in maniera davvero stupefacente, horror e politica. Il tutto, incredibile dictu, in soli tre versi. Un haiku di sfrenata, pazzesca creatività. Glielo avessero detto, a Max Brooks, ci avrebbe scritto sopra pagine, pagine e pagine: ne sono più che convinto. Voi sapete, non è vero, quanto gli americani amino l'horror all'italiana: ne fa fede, ed è solo uno dei tanti esempi possibili, il Quentin Tarantino innamorato perso dei film di Mario Bava e di Lucio Fulci.
Pensate: in Italia, ben otto anni prima di George Romero e del suo straordinario, seminale, “La notte dei morti viventi”, Fausto Amodei si inventa una storia da brividi che mescola, in maniera davvero stupefacente, horror e politica. Il tutto, incredibile dictu, in soli tre versi. Un haiku di sfrenata, pazzesca creatività. Glielo avessero detto, a Max Brooks, ci avrebbe scritto sopra pagine, pagine e pagine: ne sono più che convinto. Voi sapete, non è vero, quanto gli americani amino l'horror all'italiana: ne fa fede, ed è solo uno dei tanti esempi possibili, il Quentin Tarantino innamorato perso dei film di Mario Bava e di Lucio Fulci.











 Questo qui, Madonna bona!, non avea manco finito di imparucchiare quattro sue scolaresche certezze, che son qua mè son qua mè, a fo tutt mè a fo tutt mè. Venuto dalla più sciapita semplicità, parolaio da raduno communitosi del più misero bagaglio di frasi fatte, tolse ecco a discendere secondo fiume dietro al numero. A sbraitare, a minacciare i fochi ne' pagliai, a concitare ed esagitare le genti: e pervenne infine, dopo le sovvenzioni del capitale e dopo una carriera da spergiuro, a depositare in càtedra il suo deretano di Pirgopolinice smargiasso, addoppiato di pallore giacomo-giacomo, cioè sulla cadrèga di Presidente del Conziglio in bombetta e guanti giallo canarino.
Questo qui, Madonna bona!, non avea manco finito di imparucchiare quattro sue scolaresche certezze, che son qua mè son qua mè, a fo tutt mè a fo tutt mè. Venuto dalla più sciapita semplicità, parolaio da raduno communitosi del più misero bagaglio di frasi fatte, tolse ecco a discendere secondo fiume dietro al numero. A sbraitare, a minacciare i fochi ne' pagliai, a concitare ed esagitare le genti: e pervenne infine, dopo le sovvenzioni del capitale e dopo una carriera da spergiuro, a depositare in càtedra il suo deretano di Pirgopolinice smargiasso, addoppiato di pallore giacomo-giacomo, cioè sulla cadrèga di Presidente del Conziglio in bombetta e guanti giallo canarino.


 Cerca di essere sportivo, dai: visto che tu e i tuoi amici, assolutamente indisturbati, ve le state cercando da tanto, tanto tempo, non dovreste aver poi troppo da lamentarvi.
Cerca di essere sportivo, dai: visto che tu e i tuoi amici, assolutamente indisturbati, ve le state cercando da tanto, tanto tempo, non dovreste aver poi troppo da lamentarvi. Il primo se l'è presa, dalle pagine del suo blog (www.vaicolmambo.ilcannocchiale.it), con "questi ayatollah all'amatriciana", rei di aver bollato Ratzinger come il "nemico della scienza e della laicità" ma che "non spendono una parola, una, una sola, contro l'Iran negatrice della Shoah o contro il terrorismo assassino". Secondo Caldarola, "la minaccia contro il Papa è un evento drammatico, culturalmente e civilmente". Culturalmente "perchè rivela che c'è una parte di cultura laica che non ha argomenti e demonizza, non discute come la vera cultura laica ma crea mostri". Civilmente perchè "non si sa come spiegare alla gente comune, non a baroni rossi che hanno scritti libri fondati sui tesi infondate, perchè il papa dei cattolici è ospite sgradito nell'Università della capitale della Repubblica".
Il primo se l'è presa, dalle pagine del suo blog (www.vaicolmambo.ilcannocchiale.it), con "questi ayatollah all'amatriciana", rei di aver bollato Ratzinger come il "nemico della scienza e della laicità" ma che "non spendono una parola, una, una sola, contro l'Iran negatrice della Shoah o contro il terrorismo assassino". Secondo Caldarola, "la minaccia contro il Papa è un evento drammatico, culturalmente e civilmente". Culturalmente "perchè rivela che c'è una parte di cultura laica che non ha argomenti e demonizza, non discute come la vera cultura laica ma crea mostri". Civilmente perchè "non si sa come spiegare alla gente comune, non a baroni rossi che hanno scritti libri fondati sui tesi infondate, perchè il papa dei cattolici è ospite sgradito nell'Università della capitale della Repubblica". E la (bruttissima) Livia Turco da Morozzo (CN)?
E la (bruttissima) Livia Turco da Morozzo (CN)?
 Secondo Pirani, la scuola italiana ha ormai da tempo rinunciato alla qualità dell'insegnamento in nome di un permissivismo demenziale con cui si è fatto credere ai ragazzi che “potevano largamente infischiarsene del rispetto della lingua nazionale (ma anche delle altre discipline, dalla matematica alla storia)”. Una delle bestie nere del giornalista è l'inesauribile inventiva di certi pedagogisti nostrani (professionisti a contratto di chiarissima fama, servitori assai stimati di due padroni, i ministri dell'istruzione Luigi Berlinguer e Letizia Moratti, Franza o Spagna purché se magna!). Cito da un articolo apparso su Repubblica sabato 20 ottobre 2007, La scuola nel paese dei balocchi: “chi alla fine dell'anno si mostrava assolutamente carente gli si dava un voto virtuale, un sei rosso, come veniva chiamato, perché era scritto sui quadri finali con questo colore. Poi lo si nascose in nome della privacy e la carenza è stata, finora, resa nota per lettera ai genitori, con l'informazione che, per ogni materia con insufficienza grave, il loro figliolo era gravato da un “debito” che avrebbe dovuto saldare negli anni seguenti. Ma in tutto quest'arco di tempo solo uno studente su 4 si è dimostrato capace di saldare i debiti entro la fine del successivo anno scolastico. La maggioranza ne esce fino al termine dei corsi con una serie di promozioni che si portano in seno una sequela di bocciature, cancellate artificiosamente”. Perché questo è accaduto, negli ultimi anni, nella scuola italiana.
Secondo Pirani, la scuola italiana ha ormai da tempo rinunciato alla qualità dell'insegnamento in nome di un permissivismo demenziale con cui si è fatto credere ai ragazzi che “potevano largamente infischiarsene del rispetto della lingua nazionale (ma anche delle altre discipline, dalla matematica alla storia)”. Una delle bestie nere del giornalista è l'inesauribile inventiva di certi pedagogisti nostrani (professionisti a contratto di chiarissima fama, servitori assai stimati di due padroni, i ministri dell'istruzione Luigi Berlinguer e Letizia Moratti, Franza o Spagna purché se magna!). Cito da un articolo apparso su Repubblica sabato 20 ottobre 2007, La scuola nel paese dei balocchi: “chi alla fine dell'anno si mostrava assolutamente carente gli si dava un voto virtuale, un sei rosso, come veniva chiamato, perché era scritto sui quadri finali con questo colore. Poi lo si nascose in nome della privacy e la carenza è stata, finora, resa nota per lettera ai genitori, con l'informazione che, per ogni materia con insufficienza grave, il loro figliolo era gravato da un “debito” che avrebbe dovuto saldare negli anni seguenti. Ma in tutto quest'arco di tempo solo uno studente su 4 si è dimostrato capace di saldare i debiti entro la fine del successivo anno scolastico. La maggioranza ne esce fino al termine dei corsi con una serie di promozioni che si portano in seno una sequela di bocciature, cancellate artificiosamente”. Perché questo è accaduto, negli ultimi anni, nella scuola italiana. Cito una simpatica giornalista, la Concita De Gregorio: “Non so dire con precisione cosa sia successo nella scuola italiana dal tempo dei nostri genitori (Dante e Ariosto a memoria, capacità di tradurre all'impronta quasi intatta oggi, a sessant'anni dalla maturità) al nostro (vaghe reminiscenze di antiche fatiche) a quello dei nostri figli”.
Cito una simpatica giornalista, la Concita De Gregorio: “Non so dire con precisione cosa sia successo nella scuola italiana dal tempo dei nostri genitori (Dante e Ariosto a memoria, capacità di tradurre all'impronta quasi intatta oggi, a sessant'anni dalla maturità) al nostro (vaghe reminiscenze di antiche fatiche) a quello dei nostri figli”.




 “Condividiamo appieno la lettera di critica che il collega Marcello Cini ha inviato al Rettore dell'Università La Sapienza di Roma a proposito della sconcertante iniziativa che prevede l'intervento di Benedetto XVI all'Inaugurazione dell'Anno Accademico alla Sapienza (lettera che sostiene l'inopportunità dell'intervento e alla quale non è stata data finora risposta).
“Condividiamo appieno la lettera di critica che il collega Marcello Cini ha inviato al Rettore dell'Università La Sapienza di Roma a proposito della sconcertante iniziativa che prevede l'intervento di Benedetto XVI all'Inaugurazione dell'Anno Accademico alla Sapienza (lettera che sostiene l'inopportunità dell'intervento e alla quale non è stata data finora risposta).
 Cominciamo con un testo di Leonardo Sciascia pubblicato nella rubrica Quaderno, sul quotidiano L'ora di Palermo, il 30 gennaio 1965. Occhio a quanto Sciascia scrive di Aldo Moro (del “mito” Moro...). Ho scelto di evidenziare in neretto alcune parole.
Cominciamo con un testo di Leonardo Sciascia pubblicato nella rubrica Quaderno, sul quotidiano L'ora di Palermo, il 30 gennaio 1965. Occhio a quanto Sciascia scrive di Aldo Moro (del “mito” Moro...). Ho scelto di evidenziare in neretto alcune parole. Constatazione, questa, che Pasolini fa non senza dolore ed orrore: così come un medico, per quanto addolorato, non può fare a meno di registrare il decesso di un paziente; che sarebbe, in questo caso, l'asse linguistico Roma-Firenze.
Constatazione, questa, che Pasolini fa non senza dolore ed orrore: così come un medico, per quanto addolorato, non può fare a meno di registrare il decesso di un paziente; che sarebbe, in questo caso, l'asse linguistico Roma-Firenze. La lingua di Moro
La lingua di Moro Genialmente, bisogna riconoscerlo, l'onorevole Moro ha inventato un più rigoroso, quasi scientifico non dire. E' sua, se non ricordo male, la trovata delle convergenze parallele: che non significano assolutamente niente, né nella logica astratta né in quella delle cose concrete. E chi l'ha sentito e visto in televisione non può non condividere l'impressione dell'ineffabile non senso che l'onorevole Moro comunica. “Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto!”
Genialmente, bisogna riconoscerlo, l'onorevole Moro ha inventato un più rigoroso, quasi scientifico non dire. E' sua, se non ricordo male, la trovata delle convergenze parallele: che non significano assolutamente niente, né nella logica astratta né in quella delle cose concrete. E chi l'ha sentito e visto in televisione non può non condividere l'impressione dell'ineffabile non senso che l'onorevole Moro comunica. “Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto!”

 P.S.
P.S.
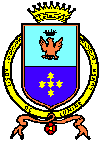 Il riferimento alle scorie nucleari, ve lo dico subito così poi non ci pensiamo più, si riferisce all'annosa vicenda dell'impianto Eurex, gestito da quella Sogin che dovrebbe occuparsi al meglio dei nostri impianti nucleari. In passato qualche genio della stirpe pensò bene che si potesse far sorgere un comprensorio nucleare in un'area immediatamente a ridosso della Dora Baltea, corso d'acqua ad altissimo rischio esondazioni (le ultime si sono verificate nel 1997 e nel 2000). E perciò il comprensorio di Saluggia racchiude ben tre attività incentrate sul nucleare: il citato deposito Eurex (prima gestito dall'Enea) destinato al ri-processamento di elementi di combustibile, poi l'Avogadro, che ospitava un piccolo reattore di ricerca (successivamente utilizzato dall'Enel come deposito temporaneo per il combustibile irraggiato) e infine l'installazione radiochimica del gruppo Sorin-Biomedica. Nel 2006 alcuni articoli de Il Manifesto denunciarono, per la prima volta, perdite di acqua radioattiva dalla piscina dell'impianto Eurex, contenente ben 52 barre di uranio. L'Arpa-Piemonte in seguito non solo confermò che l'intercapedine della piscina presentava delle perdite, ma rilevò che la contaminazione aveva interessato le falde acquifere.
Il riferimento alle scorie nucleari, ve lo dico subito così poi non ci pensiamo più, si riferisce all'annosa vicenda dell'impianto Eurex, gestito da quella Sogin che dovrebbe occuparsi al meglio dei nostri impianti nucleari. In passato qualche genio della stirpe pensò bene che si potesse far sorgere un comprensorio nucleare in un'area immediatamente a ridosso della Dora Baltea, corso d'acqua ad altissimo rischio esondazioni (le ultime si sono verificate nel 1997 e nel 2000). E perciò il comprensorio di Saluggia racchiude ben tre attività incentrate sul nucleare: il citato deposito Eurex (prima gestito dall'Enea) destinato al ri-processamento di elementi di combustibile, poi l'Avogadro, che ospitava un piccolo reattore di ricerca (successivamente utilizzato dall'Enel come deposito temporaneo per il combustibile irraggiato) e infine l'installazione radiochimica del gruppo Sorin-Biomedica. Nel 2006 alcuni articoli de Il Manifesto denunciarono, per la prima volta, perdite di acqua radioattiva dalla piscina dell'impianto Eurex, contenente ben 52 barre di uranio. L'Arpa-Piemonte in seguito non solo confermò che l'intercapedine della piscina presentava delle perdite, ma rilevò che la contaminazione aveva interessato le falde acquifere.
 Ne cito qualche passo: “Faldella è l'Omero di questa parte di Piemonte che confina a occidente con Gozzano, a sud con Camerana e Tarchetti, a nord con Cagna, a oriente con Dossi. Da qui, nelle giornate di vento, si vedono le guglie e i pinnacoli del Gadda talmente vicini che crederesti di toccarli con mano. E che respiro, che fiato c'è nelle pagine del Nostro!”. Ancora? Ancora: “Personalmente ritengo che se avesse avuto un vizio qualsiasi Faldella poteva diventare, come niente, il nostro maggior scrittore moderno. Ne aveva – direbbe l'enologo – il nerbo e la stoffa. Bastava solo che si ubriacasse; che fosse un poco omosessuale, come Gadda; che avesse amori furtivi; che fiutasse. Che fosse prodigo, o avaro. Che insidiasse i bambini per strada. Che guardasse dalle serrature dei cessi le signore mentre facevano la pipì”, e via cazzeggiando.
Ne cito qualche passo: “Faldella è l'Omero di questa parte di Piemonte che confina a occidente con Gozzano, a sud con Camerana e Tarchetti, a nord con Cagna, a oriente con Dossi. Da qui, nelle giornate di vento, si vedono le guglie e i pinnacoli del Gadda talmente vicini che crederesti di toccarli con mano. E che respiro, che fiato c'è nelle pagine del Nostro!”. Ancora? Ancora: “Personalmente ritengo che se avesse avuto un vizio qualsiasi Faldella poteva diventare, come niente, il nostro maggior scrittore moderno. Ne aveva – direbbe l'enologo – il nerbo e la stoffa. Bastava solo che si ubriacasse; che fosse un poco omosessuale, come Gadda; che avesse amori furtivi; che fiutasse. Che fosse prodigo, o avaro. Che insidiasse i bambini per strada. Che guardasse dalle serrature dei cessi le signore mentre facevano la pipì”, e via cazzeggiando.

